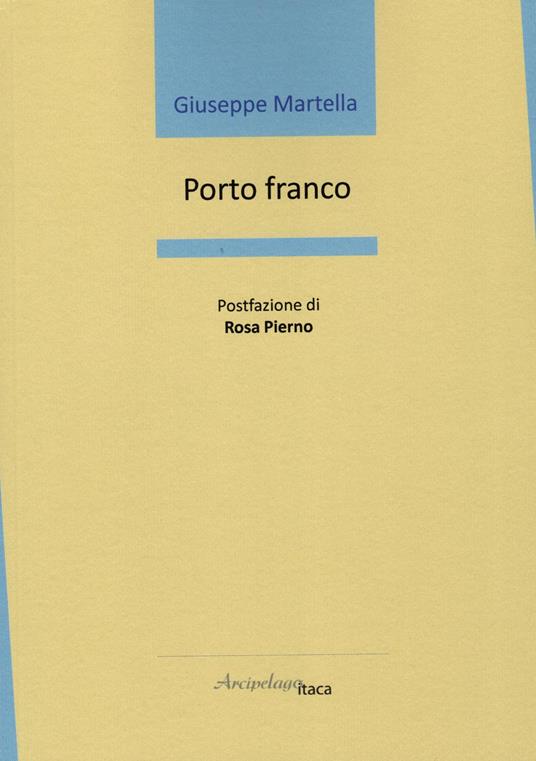
Ho sempre pensato che l’ispirazione a scrivere poesia contenga una sorta di rivelazione, una misteriosa comunicazione che dal poeta giunge al suo lettore.
Quando questo accade, ci si sente partecipi, avvolti da quella stessa aura d’ineffabilità che aveva suggerito al poeta il suo dire.
La poesia di Giuseppe Martella mi fa un incantevole effetto. È come se un respiro pronunciasse all’orecchio i suoi versi, quasi a trasmetterne uno speciale segreto.
In questi testi l’agilità sostiene la bellezza (categoria non sempre del tutto spiegabile, né confrontabile) e trasmette l’armonia in guizzi di colore imprevedibili, in un affascinante percorso poetico-filosofico che oltre alla vividezza d'immagini immediatamente fruibile dà altro significato al senso compiuto del vivere.
Sono poesie che inducono alla riflessione, come se si fosse messi di fronte a un paesaggio di cui prima non avevamo notato i particolari più importanti, così importanti che nello scorgerli appieno, ci comunicano ulteriore bellezza, pace, speranza.
cristina bove
Per ipotesi
Ma sì, ma quando, ma poi,
se tutti noi
fossimo presi per incantamento
e trasportati indietro e poi in avanti
fuori del tempo e dentro,
presi e sorpresi dai futuri istanti
indifesi
e prendessimo le cose con i guanti
al fine,
e oltre il confine dell’io ce le spartissimo
spezzando il pane insieme,
finalmente, dimenticando Iddio.
GRAN CANARIA
Gran Canaria
Azzurro, azzurro
azzurro il cielo, trasparente è l’aria
dopo la pioggia rara del mattino
fine fine battente
la pioggia mattutina a Gran Canaria.
Azzurro azzurro che scema nel celeste
celeste il cielo
azzurro il mare, bianchi i cavallucci
riccioli bianchi, spuma sulla roccia
che scende sui tuoi fianchi
isola d’aria
la pioggia mattutina ti ha vestita a nuovo
nutrito ha il poco verde, che nella roccia
si perde e al mare mira diventando muschio
mischia l’aria col sale – e fischia una leggera brezza
sul celeste che rischia di annegare –
isola d’aria persa in mezzo al mare.
***
E la figura nell’ovunque luce
svanisce e si dà pace finalmente
si piega come il gambo sulla terra
– è passato un giorno, soltanto un giorno
è passato –
la terra tace, assorbe, riconduce
tutta l’acqua di luce alla sorgente
la terra riproduce fiori e frutti
e tutti quanti ritorniamo alla terra,
tutti ritorniamo alla terra dalla luce.
***
Celeste celeste blu blu celeste
bisogna mischiare i colori
prima di trovare la tinta giusta
celeste blu blu blu celeste
e sfumare sfumare dimenticare
annegare le forme nei colori
un sollievo per l’occhio e per la mente
la forma che si pente nella vita
e si smarrisce e sfuma –
buona fortuna a te, buona fortuna.
***
E così via, raccogliendo per strada
i lacci e le conchiglie e i ricci
gli stracci – le caccole dei cani
gli impicci fra ieri e domani
raccogliendo, scartando
facendo insomma le pulci alla vita
con le dita nude –
doloranti magari, gli occhi stanchi
davanti sempre a un mucchio di rifiuti
e quanti quanti sempre più davanti
sfaticati, stenti sulla strada
quasi sfiniti tutti, tutti quanti –
quasi arrivati, e neppure mai partiti.
***
Scogliere, sassi, sterpi sui dirupi
serpi, forse annidate
nei calanchi
l’isola mostra i fianchi scavati
le gengive dei denti
avvelenati dal cemento
e sento gemere piano le radici
dei radi alberi, zolle di verde
perse nel mare d’azzurro
chiaro scuro di mare e cielo
con qualche vena di ruggine
negli occhi, qualche stilla di sangue
nell’oro di conchiglia
nell’eco martoriata dei riflussi
delle maree, dei tremiti profondi
delle faglie
nelle aeree schermaglie degli alisei,
nell’antico rifugio degli dei.
***
Ogni macchia, lasciata sulla strada
intrisa di semenze
ogni cosa derisa, attende
di essere ripresa, condivisa
come un’ostia dissacrata,
attende di essere ancora una volta
spezzata, spezzata come pane
diluita, stinta, poi bevuta
tutta d’un sorso –
la macchia sul dorso della tua mano
il fuscello nell’occhio
e dire piano, e dire piano piano
sempre più piano dire
sempre più vano il tuo fletterti
in ginocchio (pregare)
la macchia densa
che sta fra il dire e il fare.
***
E prendi la misura, giusta finché ne hai tempo
e prendi il tempo a tua misura
magari a usura, prendilo a prestito
qui se è il caso – tanto
tutto è in affitto qui un tanto al mese
il sole l’aria il mare
il passeggiare così senza pretese,
silenzioso diletto, scendere giù dal colle
senza musica né donne né locali costosi
senza neanche voci quasi
se non quelle delle onde sulle rocce
dell’ultima caletta, della casa dei ricci
dove la tua ombra ti aspetta
in un canto, il solo riparato dal sole
e lì prendi il respiro delle onde
a tua misura – inali forte, trattieni il fiato
e fiuti l’aria a occhi chiusi
salsedine aria pura
misura del respiro, finché dura.
***
L’ORA BRUNA DEL PRESENTIMENTO
Le ore sono parole da non dire
e passano altrove e si
disfanno sempre l’una e l’altra
– l’ora bruna del presentimento –
come nube leggera dagli orli illuminati
arancio, rosso perché viene
perché viene sera prima o poi
nell’ora stessa come quando bussa
alla tua porta
il pellegrino sempre più inatteso
sempre più vicino che lo confondi
col tuo stesso profilo che passa
per la cruna dell’ago,
e sì foggia un angolo protetto
come una tortora che si fa un nido
di straforo
nel sottotetto della tua dimora.
***
Non ho parenti, sono solo al mondo
sono un bimbo strambo
perennemente in cerca di adozione
se piango canto la stessa canzone
di sempre –
e mi sovviene il tuo volto parente
madre dai tanti volti ormai dispersi
semicancellati, sovraimpressi occhi sbarrati
madre che urli dalla finestra e sbracci
e mi chiami –
di giudicare io non ho il diritto
il bene e il male che mi hai fatto.
Io sono qui per te natura che non mente
sono tuo figlio, qui, sulla soglia del niente.
***
Mi disse: tu mi piaci. Sposami.
Cavolo, dissi, ci debbo pensare!
Mi guardava fisso con gli occhi spalancati
e dentro gli occhi precipitava il mare.
Sì, d’accordo, sarai dunque mia sposa
– era spuma di vento –
capelli mossi fulvi dai riflessi cangianti
Le dissi sorridendo: io però sai devo partire
sempre
sposarsi sì vabbè si fa per dire,
ci incontreremo talvolta a mezza strada
tra nord e sud tra cielo e mare
e tanto basta no? Uno sguardo al volo
un cenno della mano – sognava
ad occhi aperti – Ci sposammo
in un giorno di sole intenso sul sagrato
di una piccola chiesa – arrivai in ritardo
lei mi attendeva ansiosa ma sorridente –
in ritardo poi lo sono stato sempre
E lei sempre mi ha atteso, paziente
la mia sposa.
***
Ci siamo già lasciati: ora mi dici
non ti conoscevo a fondo
anzi per niente,
ora ritorno,
sai, saremo felici. Ma
ti guardo e mi confondo
e che sarà mai codesta ombra
che mi molesta nel caldo mezzogiorno?
E poi chi se lo aspetta mai un ritorno
dopo tanto tempo!
Ho il forno acceso e mi si brucia il timballo
di riso con cura preparato da mia moglie
– ecco qui sta l’impiccio: le doglie della vita
i rami spogli, sparuti
stenti
che seguono al cadere delle foglie.
***
Andare e non andare: non capire
venire al dunque, poi perseverare
fuggire all’ultima ora
– ora è lo stesso –
e mi capita spesso quest’ora incerta
dove non so chi sono,
e non so a chi chiedo, se mai chiedo
per forza o per amore. Se
tu ci fossi, e se non fossi io,
chiederei perdono a te – perdono a Dio.
Postfazione
di Rosa Pierno
Attraverso la lettura della prima raccolta poetica di Giuseppe Martella, Porto franco, si scopre di essere entrati in uno studiolo degli esperimenti in cui le ipotesi, che sono già normalmente coltivate in un ambito di incertezza, sono, per sopraggiunta istanza sperimentale, anche immerse nella contraddizione. Ciò fa diventare la miscela esplosiva, ancor prima che sulfurea. Si tratta di ipotesi di lavoro tenacemente attaccate alle loro confutazioni come le peonie di mare allo scoglio: non pongono soluzioni che preve-dano la distinzione, l’operabilità della differenza. Designano un luogo non alchemico, che tuttavia produce l’affondo sui limiti del pensabile. Ne consegue che risultano nettamente delineati anche i profili delle aggettanti ombre in campo ludico. Codesta attitudine della poesia è irrinunciabile, essendo essa artificio. La poesia porta con orgoglio tale medaglia; ciò equivale a porre la sua ironica lungimiranza in bella mostra!
Ma per meglio intendere i termini della questione e la modalità con cui il poeta affronta tale tenzone, è necessario definire le due minacciose leve della tenaglia, ma anche gli stati d’animo in gioco. Le prime poesie, briose, allegre, di una sorprendente levità e ariosità, aventi sonorità rapenti, un certo ravvivato fischiare montaliano, indicano che la vita e la morte sono espresse all’interno dei cicli della rinascita. Le forme compiute si sfaldano in una giostra di nuovi inizi. Ad uno sguardo più ravvicinato, lontano dalle alte sfere, le cose appaiono come resti, rifiuti, inutili ingombri. Un tarlo buca l’areostato, le sensazioni (quelle sensazioni che Mach eleggeva come unico elemento da prendere in considerazione) divengono numericamente ingestibili: la spola istituita tra la sfera dei processi e quella degli oggetti produce dolore, il male di vivere. L’indivisibilità a cui accennavamo all’inizio fa parte di un pacchetto ingovernabile: non si può ordinare, non si può separare il bene dal male, non si può trovare un senso unitario che inglobi l’esistente. Se è vero che non sembra esserci alcun punto di contatto fra la meraviglia che il creato suscita e il «cartoccio di paranza fresca» del desinare e se persino la vita ritorna «secca e muta nei suoi argini», tuttavia non ha senso nemmeno separare l’afflato che comunque si prova per il cosmo e per la propria esistenza. In fondo, l’aria sembra essere, e vale per l’intera raccolta, un filo rosso: l’aria che ritempra e gli aperti spazi del cosmo che ridimensionano formano una sorta di oscillazione che ruota su un medesimo perno. Misura e dispersione procedono insieme.
Dal materialismo iniziale Martella giunge ben presto al recupero di ciò che è spirituale. Regge poco il materialismo delle prime fasi, della gioventù, la lucreziana danza degli atomi. Presto giunge il momento in cui pregare fa parte dell’oscillazione: «sempre più vano il tuo fletterti / in ginocchio (pregare)». La luce abbagliante si mostra in grado di chetare l’animo. D’altra parte, la morte non è esorcizzabile, anche se inserita in un ciclo «e spreme e preme alla bocca dell’anima / come un vuoto pulsante: la paura». Il corpo stesso viene vivisezionato e ricomposto «nei meandri di un labirinto / senza centro». Veri e propri miraggi di concerto con le sembianze polimorfiche di un io che risente del passaggio nelle varie età esistenziali fino ad assumere le forme della natura, la voce del mare. In questo senso, la raccolta si configura come un poemetto delle varie fasi della vita sullo sfondo della ciclicità co-smica. E diversa è dunque la voce iniziale, primaverile, aerea del-le prime poesie e quella dorata, e in svolgimento amorfo dell’età più matura.
In siffatto moto, il sistema linguistico è messo alle strette, non tramite una riduzione delle sue componenti poetiche, ma attraverso equivalenze e sostituzioni concettuali. Senza cioè sopprimere le potenzialità ritmico-intonazionali del verso, il lavoro poetico di Martella si svolge tramite la messa a tema di concetti culturalmente inseparabili: Dio-luce, colore-forma. Per ipotesi, è infatti una poesia che esplicita proprio tale teorema: quei sistemi di idee che tentano di narrare di Dio, («fuori del tempo e dentro», «oltre il confine dell’io») eliminando l’idea del divino che è associato ad essi, non suonano forse come svuotamento dei concetti che dovrebbero suffragare? Non determinano, cioè, l’annullarsi del secondo termine dell’uguaglianza? Ecco dunque che l’inseparabilità, solo apparentemente paradossale, è in realtà pienamente artificiale e giunge alla sua maggior altezza nel linguaggio poetico, lì vivendo interamente la sua complessità.
La possibilità di giungere a qualcosa, se mai sia possibile giungervi, è per Giuseppe Martella intimamente legata alla valorizzazione dei detriti esistenziali, concretissimi, come è estratta da beckettiana memoria. Da tale repertorio proviene quel gusto per le cose infime che fa scopa con il gusto per i segni: «ogni cosa derisa, attende / di essere ripresa, condivisa / come un’ostia dissacrata». La valorizzazione semantica è il luogo ove avviene lo scambio con la realtà, ove la macchia diviene senso, staccandosi definitivamente dal reale per andare a sistemarsi nella rete dell’artefatto culturale. Tuttavia, quello che si è costruito, anche faticosamente, finisce col reclamare a gran voce d’essere disperso: le forme sono da dissipare, quasi per un agognato ritorno a quel caos primigenio, ove regna l’indistinto o, meglio, in quel dondolio perenne tra terra e luce, laddove si osserva che la spola tra ciò che è materiale e ciò che è astratto è tessuta fittamente. Anche la sonorità soffusa, lieve, (mente-pente, sfuma-fortuna) che si rincorre tra ripetizioni lessicali, sostanzia l’impianto semantico. L’ef-usione intimista, una vera e propria ode al presente, ai suoi momenti concreti e fugaci, di cui la marca più certa e afferrabile sono i colori, quei bianchi, sfolgorati come un assoluto, quei verdi smaglianti dell’infanzia, quell’azzurro che dismette la propria forma, quell’effusione, dicevo, di marca affettuosa, vale certamente una riconciliazione con l’esistente.
E, pur tuttavia, è la sonorità che s’impone sull’immagine, nella lettura: «stanno / come faci, tremule, falci / tralci di vite, recise o quasi / i vasi dei fiori appassiti / nelle dimore vuote, o quasi». È nella volontà del poeta di sottolineare la specificità di una pratica che, in quanto costruita con parole, egli si propone di smerigliare al meglio, facendo tintinnare il lessico fino all’intersezione sonora. Con il suono, che fa intrinsecamente parte del senso, Martella costruisce al contempo il resoconto della sua vita, non nel mezzo del cammin, ma su un liminare confine dove si piega e ripiega, come una canna al vento, la possibilità umana di render conto dell’assoluta inconciliabilità dell’ordine cosmico e dell’ordine umano. E, tuttavia, come dicevamo, essi procedono fianco a fianco,
inestricabilmente.
Non rimpianti, ma un accordo da stringere con se stesso, un dichiararsi soddisfatto al saldo, perché è giocoforza farlo, e così tenere a bada le insoddisfazioni che mordono il fianco: «da invisibili venti – e poi ce n’è sempre / uno che mi rode dentro / (un topo forse – forse un presentimento) / e non si acquieta / fra lacrime e sorrisi» tale da essere una dieta quotidiana, «quel codice prescritto / che mescola gli inferni ai paradisi». Non si tratta degli inevitabili rimpianti, dunque, ma della ricucitura, del completamento delle frasi non dette, mal intese, presupposte, tali che la loro consistente numerosità viene a formare un’esistenza dissimile, altra, da quella effettivamente vissuta. La memoria ricostruisce a suo piacere il dato esistenziale, rifondendogli nuova vita e piegandolo a nuove conformazioni. La splendida poesia sulle ore, che apre la seconda sezione, ha la grazia di rendere presente, per mezzo del ricordo, una rivisitata esistenza, ora finalmente intravista in quella vissuta, ma anche di renderla corpo visibile per i lettori, forgiando contemporaneamente un materiale modellabile al fine di saggiare le ipotesi, di visitare le strade non intraprese, di ripristinare ciò che è stato malamente interrotto. Ipotesi che riguardano il senso dell’esistere, proiettato nel cielo e da lì nuovamente rifratto sulla terra, come se il cielo fosse uno specchio ustorio. Le forze emanate da uno stato indeterminato, dubbioso, sembrano ritornare concentrate, capaci, oramai, di rendere il senso disperso un senso conclusivo.
Insomma, l’analisi svela un delirio prismatico che coinvolge l’io. L’ipotesi unitaria su scala macroscopica diviene un ologramma in cui si disfa il mondo. Intatto resta ciò che sfugge al poeta, ciò che lo sovrasta. Ma l’ipotesi iniziale tiene. La vita è stata vissuta e mille cicli sono presenti in una sola vita.
Nella bellissima Canone inverso si coglie appieno il senso dialogico dell’impostazione poetica di Giuseppe Martella, che nel suo traghettare inesausto di novello Caronte, che ancor non si dà pace per il trasporto da effettuare da una sponda a un’altra, vive i ricordi indistintamente dal presente, la morte come non differente dalla vita. Egli, ritorcendo i fili di quelle sue occorrenze quotidiane, che passerebbero altrimenti come un puro insignificante accadimento, le rifonde nelle trame, visive e sonore, delle sue dorate filigrane ove tutto si tiene.
